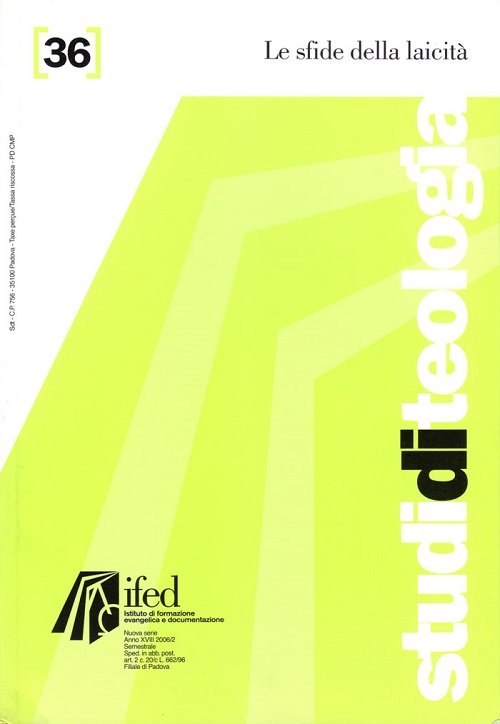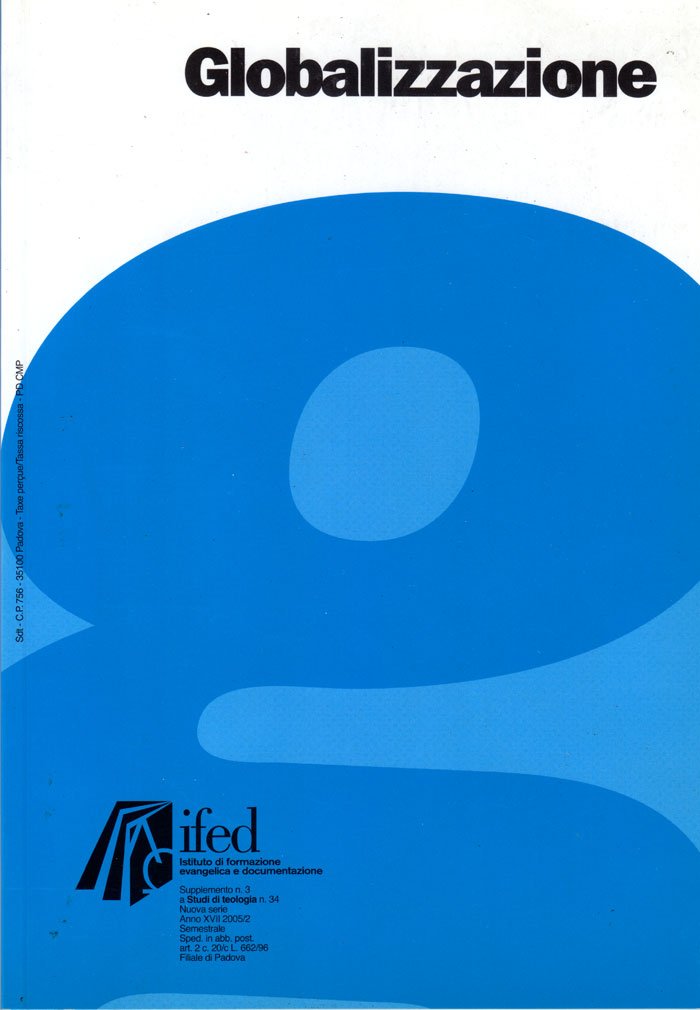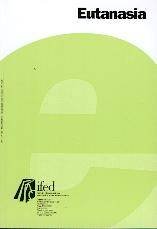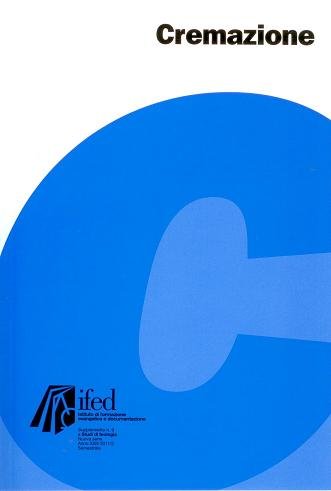Area dell’etica
-
AA.VV., Le sfide della laicità, Ed. IFED, Padova, Studi di Teologia N. 36/2006
La laicità è un punto d’incontro tra tre fattori: il rispetto del pluralismo sociale, la possibilità per tutti di partecipare alla vita pubblica con la propria specificità (anche religiosa) e il pari trattamento da parte dello Stato nei confronti di tutte le componenti della società. In Italia il tasso di laicità esistente presenta molti punti problematici per condizioni storiche e culturali che caratterizzano il nostro Paese… ci vogliono categorie nuove che promuovano un percorso virtuoso di assimilazione di laicità. Forse la cultura evangelica, eredi di un pensiero che ha riconosciuto nel pluralismo un valore da promuovere, può dare un contributo significativo in questa direzione.
-
AA.VV. Stranieri con noi, Ed. IFED, Padova, Studi di Teologia, suppl. N. 7/2009
L’Occidente si trova spiazzato di fronte ad un fenomeno sempre esistito e praticato, ma vissuto oggi come elemento turbatore di un equilibrio precario e fragile. Contro un superficiale ed idealistico ottimismo delle differenze, si fa strada una crescente e preoccupante inquietudine dell’altro. Il tema dell’accoglienza è morale in quanto investe i valori di riferimento di una comunità in relazione ad altre comunità. L’incontro con lo straniero mette in gioco tutta la propria identità e la visione del mondo di cui si è interpreti. L’estraneità è l’alterità distante e avvertita come non coinvolgente, se non proprio repellente… l’altro va incontrato, ascoltato, guardato negli occhi, per cercare di descriverlo e di comprenderlo. Chi guarda agli altri come stranieri è egli stesso straniero per loro. C’è una sorta di circolarità dell’estraneità a cui nessuno può sottrarsi.
-
AA.VV. Buon lavoro, Ed. IFED, Padova, Studi di Teologia, suppl. N. 18/2020
Il lavoro, ogni lavoro lecito e in condizioni umanamente sostenibili, è buono. Tuttavia, emotivamente parlando, spesso il lavoro viene associato ad un vissuto segnato da negatività, tensioni, insoddisfazione, conflitti o dissociazione. Oppure viene idealizzato e magari ideologizzato… ma la “buona notizia” cristiana è che possa essere rivissuto non fuggendolo, non essendone sopraffatti, ma recuperandone la dignità, ricostruendone la socialità rilanciandone le finalità, nella presa in carico della complessità.
-
AA.VV. Intelligenza artificiale, Ed. IFED, Padova, Studi di Teologia, suppl. N. 19/2021
La tecnologia ha fatto così tanti passi in aventi che ha determinato uno scatto rivoluzionario di magnitudo storica. L’Intelligenza artificiale (IA) è il simbolo della quarta rivoluzione. Le macchine intelligenti sono più veloci e performanti degli esseri umani, costano ma non ricevono lo stipendio, non vanno in ferie, non dormono, non si ammalano… acquisiscono sempre di più lo status di agenti artificiali morali. Da mezzi a soggetti, da str4umenti ad attori. La soglia della moralità è stata attraversata? Quali limiti devono essere posti (imposti?) affinché le creazioni umane non sfuggano di mano agli esseri umani stessi? Quali effetti di lungo periodo sul mercato del lavoro, sui processi democratici e sulle istituzioni politiche? L’IA non è più solo un argomento per addetti ai lavori, ma i suoi studiosi e ricercatori sono al centro dell’azione politica. Questo è un motivo ulteriore per promuovere una riflessione allargata e partecipata.
-
AA.VV. Aborto, Ed. IFED, Padova, Studi di Teologia, suppl. N. 6/2008
In molti sensi, l’aborto è una questione paradigmatica per la bioetica. Intorno a questo tema si può scrivere la (breve) storia della bioetica, in quanto la discussione contemporanea è entrata nel vivo negli anni Settanta proprio sull’interruzione volontaria della gravidanza… Si può dire che l’aborto abbia avuto una funzione d’apripista e di orientamento la cui portata è andata ben oltre la questione specifica. A distanza di trent’anni, si può fare qualche osservazione critica. Il dibattito ha dato l’impressione che ci fossero due grandi opzioni - una a tutela della vita nascente, l’altra a sostegno dei diritti della donna, e che fossero radicalmente contrapposte. Così facendo, ha male instradato il dibattito bioetico, riducendolo a un conflitto tra valori con la V maiuscola e diritti assoluti ed impoverendolo rispetto alla complessità delle situazioni concrete. Serve un altro paradigma che valorizzi la vita e le scelte all’interno di una triangolazione tra valori di riferimento, responsabilità dei soggetti coinvolti e situazioni diverse che via via si presentano.
-
AA.VV. Unioni civili, Ed. IFED, Padova, Studi di Teologia, suppl. N. 12/2014
Un’istituzione sociale che nel corso dei millenni è stata punto di riferimento sostanzialmente universale e stabile è stato il matrimonio tra un uomo e una donna. Questo patto, accordo o impegno per la vita è stato il cardine della società. Ora, nell’Occidente secolarizzato, siamo in presenza di una spinta non solo al riconoscimento di altre forme di convivenza rispetto al matrimonio, ma al tentativo della ri-definizione stessa del matrimonio. Il tema è di primaria importanza. Quale statuto sociale riconoscere alle coppie di fatto, eterosessuali o omosessuali che siano? Quali diritti? Quale configurazione pubblica? Quale livello di “normalità”? Quali attese di genitorialità? Nel mondo cristiano si confrontano posizioni diverse tra loro. Il tema delle unioni civili mette alla prova la capacità di onorare gli ordinamenti della vita creata nella particolarità della condizione storica vissuta.
-
AA.VV. Etica della cura, Ed. IFED, Padova, Studi di Teologia, suppl. N. 17/2019
L’etica della cura è un orientamento della bioetica che, in risposta e in relazione alle tendenze etiche che sottolineano l’imparzialità e l’universalità di istanze come la giustizia e l’autodeterminazione dei soggetti, mette invece in risalto la partecipazione, la concretezza della relazione e la vicinanza umana. All’autonomia delle etiche liberali, l’etica della cura contrappone l’alterità in relazione, l’essere con l’altro e vicino all’altro. All’etica dei principi, talvolta declinati in modo troppo astratto e teorico, preferisce l’etica dell’incontro tra persone uniche ed in carne e ossa. Nata all’interno del pensiero femminile, l’etica della cura è “l’attitudine a integrare, nella pratica sanitaria, competenza tecnica e sensibilità umana, un “appello alle persone a prendersi cura reciprocamente del destino dell’altro in modo responsabile in un processo di reazione alla vulnerabilità”. L’etica cristiana sembra essere ben posizionata per accogliere le istanze dell’etica della cura, anzi, sarebbe difficile pensare all’etica della cura se non come ad uno sviluppo di un “capitale preso in prestito” dal cristianesimo.
-
AA.VV. Etica animale, Ed. IFED, Padova, Studi di Teologia, suppl. N. 11/2013
Il rapporto uomo-animale situato nel nostro ecosistema ha costituito una trama tanto centrale quanto progressivamente scontata durante tutto il corso della storia. Un fatto che rimane chiaro è che fintanto che l’umanità sarà presente sulla faccia della terra, finché gli animali saranno presenti, questi due gruppi vivranno fianco a fianco nella realtà che condividono, e non è il se ma il come questo rapporto è costituito che farà la differenza. È necessario individuare le opinioni/rivendicazioni più significative nel dibattito contemporaneo rispetto allo status del mondo animale, nonché le traiettorie etiche che le caratterizzano. Il compito dell’etica evangelica, tuttavia, non è un tentativo solo esplorativo ma anche propositivo. Di qui la responsabilità di presentare un approccio che può essere definito antropocentrismo relazionale.
-
AA.VV. Testamento biologico, Ed. IFED, Padova, Studi di Teologia, suppl. N. 15/2017
Il tema del testamento biologico non può essere scollegato da una più ampia riflessione sul fine vita e l’etica evangelica ha una responsabilità di attivare un dibattito interno e pubblico. Al di là di tante considerazioni che si possono fare sul testamento biologico, quale è la sua rilevanza culturale per un Paese come il nostro, in cui la morte è ancora soggetta a blocchi paralizzanti? In un lavoro di riforma culturale, un ruolo importante può essere svolto dalla testimonianza cristiana di credenti pacificati con la propria morte, il passaggio che tutti dovremo affrontare.
-
AA.VV. Globalizzazione, Ed. IFED, Padova, Studi di Teologia, suppl. N. 3/2005
La globalizzazione è al centro di molti discorsi. Uno dei rischi è di parlarne in modo asettico e scolastico, come un insieme di numeri e concetti. Non c’è dubbio che una maggiore consapevolezza della complessità delle questioni sia necessaria. Eppure, fornire nozioni sulla globalizzazione senza promuovere una globalizzazione umana significa consolidare una globalizzazione malsana. Ecco perché bisogna intrecciare l’informazione e la formazione in vista della trasformazione.
-
AA.VV. Genere/Gender, Ed. IFED, Padova, Studi di Teologia, suppl. N. 13/2020
C’era una volta il genere. Legato al sesso di appartenenza (maschile o femminile), il genere era un modo culturale, personale, biografico di interpretare la propria sessualità. Come il resto della vita, anche il genere era ed è soggetto alle distorsioni del peccato e nella necessità di essere guarito dalla grazia divina. Ora c’è il gender. Indifferenziato rispetto al sesso, esso si presenta come un kit da montare a piacimento nelle sue molteplici variabili e soggetto solo alla decisione rivedibile dell’individuo, un mero costrutto culturale senza alcun rapporto con il sesso. Ora il gender è stato ideologizzato ed è diventato una verità assoluta da impartire alle giovani generazioni per liberarle dai vincoli residui delle costrizioni del sesso e per aprire loro un mondo liquido… il gender non vuole solo una cittadinanza culturale in uno spazio plurale, ma ambisce a cancellare la possibilità per altri pensieri di abitare quello spazio in nome di una “correttezza culturale” dai tratti arroganti. Si tratta di grandi questioni, che impegneranno questa generazione e la prossima. Lavorando per il pieno riconoscimento del pluralismo e della piena libertà di parola, questo è il contributo che la minoranza evangelica può e vuole dare alla discussione in corso.at.
-
AA.VV. Transizione ecologica, Ed. IFED, Padova, Studi di Teologia, suppl. N. 20/2022
Quella ambientale è una delle sfide pressanti della nostra generazione, che affonda le sue radici in fenomeni osservabili a partire dalla fine del XVIII secolo. Quello che c’è di nuovo è che la situazione di degrado e sfruttamento ambientale ha raggiunto livelli inimmaginabili fino a pochi decenni fa. In secondo luogo, è innegabile che l’attenzione mediatica sui temi ambientali è ormai ai massimi livelli… a livello legislativo i governi, a partire dagli anni ’90 si sono dati degli impegni più o meno vincolanti. A questo sfondo culturale, la transizione ecologica introduce l’istanza del cambiamento, della trasformazione, del passaggio da un assetto della realtà ad un altro. Soltanto una visione del mondo che sia coerente con il racconto biblico di creazione, caduta, redenzione e consumazione rende ragione da un lato della bontà del creato, dall’altro del motivo vero e profondo della crisi e dall’altro ancora del rimedio definitivo e completo a cui (anche) il creato tenderà.
-
AA.VV. Eutanasia, Ed. IFED, Padova, Studi di Teologia, suppl. N. 1/2003
Sono molti i fronti su cui la riflessione bioetica è sollecitata. Tra questi, l’eutanasia è uno dei più caldi. Il dibattito, specialmente in Italia, sembra essere polarizzato tra il fronte cattolico, contrario all’eutanasia, e quello laico, in genere a favore della stessa. Questi orientamenti, tuttavia, non esauriscono le posizioni in campo. Anzi, finiscono per appiattirle se la discussione pubblica si accontenta pigramente di un bipolarismo culturale ingessato e non si apre a un vero pluralismo. La cultura evangelica contesta il duopolio cattolico-laico in ambito etico e scommette sull’introduzione di un patrimonio culturale diverso, anche per quanto riguarda la questione dell’eutanasia.
-
AA.VV. Etica dell’ambiente, Ed. IFED, Padova, Studi di Teologia, suppl. N. 16/2018
La presenza umana sul pianeta Terra è tale che la sua attività è capace di condizionare sensibilmente i suoi cicli interni. Il problema delle risorse è una realtà terribilmente concreta. La questione non è solo come sfamare tutti in scenari ambientali soggetti a significativi cambiamenti climatici, ma è anche capire la sostenibilità ecologica di una tale presenza antropica sul pianeta. Non si tratta di questioni marginali che appassionano alcune frange politiche o alcuni movimenti particolarmente sensibili, ma si tratta di sistemi produttivi, modelli di proprietà terriera, strumenti di tutela della natura, costrutti antropologici e filosofie ecologiche che influenzano i nostri modi di percepire la realtà e l’ambiente in cui viviamo… la sfida davanti all’umanità e all’ambiente di cui facciamo parte è grande: quella non solo di “salvarci” dalle catastrofi ambientali e umanitarie di cui siamo anche causa, ma di attivare una nuova consapevolezza del creato e di sostenere progettualità che lo sostengono e favoriscano una co-esistenza più giusta.
-
AA.VV. Cremazione, Ed. IFED, Padova, Studi di Teologia, suppl. N. 9/2011
La morte è di per sé un’esperienza densa e intensa dal punto di vista morale. In particolare, chi rimane in vita deve “gestire” moralmente la morte altrui, provvedendo forme adeguate di rispetto delle persone che non sono più. Una serie di domande si affastellano nel cuore: che succede ai corpi dei morti? Che ne è dei cadaveri? Come vengono trattati? Come ci si accomiata da un morto? Dove come “riposa”? Cosa è giusto fare per rendere onore a una persona? Queste domande riecheggiano dagli albori dell’umanità. Sul trattamento dei cadaveri la cultura umana ha esercitato una delle sue missioni fondamentali. Cosa fare dei morti è una delle prime e fondamentali domande a cui l’umanità è stata chiamata a dare risposte. Ripulito il dibattito dalle sue incrostazioni ideologiche anti-cristiane, il tema della cremazione deve e può essere affrontato al netto delle paure inconsce o delle rigidità non sottoposte a vaglio autocritico.